Combattere
XXVIII Domenica T.O. –
La liturgia della Parola di questa domenica esordisce in modo assai deciso: <In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele e Refidim> (Es 17, 8). Bisogna ricordare che Amalèk secondo quanto testimoniano le Genealogie (cfr. Gn 36) proviene dalla stirpe di Esaù, legato dunque agli Edomiti con cui condivide l’atavica inimicizia con Giacobbe. Il luogo dello scontro con Giosuè (Es 17, 8) è Refidim la cui etimologia – raphah+yadim – significa avere le mani deboli. La Mekhiltà indica un <rilassamento delle mani> e così ricorda che l’Avversario appare, non appena c’è un rilassamento. Al contrario, la preghiera secondo la parola del Signore Gesù – nel Vangelo – è una <necessità> che esige un buon allenamento nella perseveranza: <senza stancarsi mai> (Lc 18, 1). La parola della <vedova> che continua ad importunare il giudice è una parabola di questa capacità della preghiera: una preghiera capace di piegare e rettificare il corso della storia, togliendo la presa al male proprio con un’attitudine di combattimento che non accetta nessuna forma di allentamento. Ritorniamo così ai tempi di Amalèk quando Mosè non lasciava cadere le sue mani mentre Giosué combatteva nella valle. Secondo la sapienza della Tradizione, la guerra contro il nemico di Dio esisterà sempre nella storia e <solo la potenza di chi ha aperto il mare, tramite il bastone di Mosé, può garantire la vittoria>1.
La lotta contro il volto di turno del nemico di Dio va fatta con perseveranza e senza arrendersi. Bisogna assiduamente perseverare nel perseguire ciò che sentiamo essere un bene necessario non solo per la nostra vita, ma – soprattutto – quando questo bene riguarda la vita e la felicità degli altri. L’apostolo Paolo si pone nella stessa linea dell’Esodo e nella stessa prospettiva di quel cammino che il Signore Gesù sta compiendo, con ferma decisione, verso Gerusalemme: <tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente> (2Tm 3, 14). Non è raro come, il pensare alla preghiera, corrisponda ad immaginare una certa dimissione nei confronti della vita e della storia. Al contrario, la preghiera è il modo remoto e profondo di preparare al meglio tutti i passi che, nella vita e nella storia, siamo chiamati necessariamente a compiere perché siano autentici e duraturi.
Una nota assai significativa, nella conclusione della parabola, è il fatto che per la sua interpretazione il Signore Gesù ricorre a due domande e non a due affermazioni, quasi indicando che la preghiera – prima di essere una risposta appagante – è un interrogativo che interpella l’interezza della nostra umana esperienza, un’esperienza percepita e vissuta al massimo grado di estensione in relazione a Dio. Così conclude il Signore Gesù: <E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui?>. Come se non bastasse c’è un altro punto interrogativo: <Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?> (Lc 18, 7-8). La preghiera non consiste nelle belle parole o nei bei sentimenti, ma nella capacità di perseverare nelle battaglie della vita anche quando ci sentiamo terribilmente soli… e Dio sarà al nostro fianco senza mai sostituirsi a noi, al fine di permetterci di gustare l’onore del combattere e la gioia di vincere.
1. E. BIANCHI, Lontano da chi?, Gribaudi, p. 203.


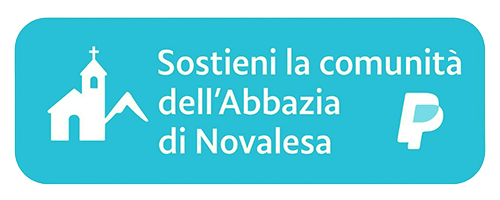


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!