Il tuo nome è Rabbì, alleluia!
III Settimana di Pasqua –
La domanda che la folla rivolge al Signore Gesù rivela come la gente avverta la necessità della sua presenza: <Rabbì, quando sei venuto qua?> (Gv 6, 25). Quando poniamo a qualcuno domande di questo tipo non facciamo che manifestare – tra le righe del nostro discorso – quanto abbiamo bisogno di questa presenza per vivere meglio, per sentirci più vivi e per avvertire quel conforto di cui abbiamo bisogno. Quello che avviene dopo la moltiplicazione e la condivisione dei pani e dei pesci, è una sorta di inseguimento tanto che <Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù>. Questa ricerca non è assolutamente vana perché <Lo trovarono al di là del mare> (6, 24-25). Questo rincorrersi un po’ ci stupisce… sia da parte della folla, sia da parte del Signore Gesù che sembra giocare a nascondino. Il motivo di tutto questo movimento può essere colto come un simbolo della preoccupazione da parte del Signore che la gente sfamata con i pani e i pesci tanto da essere rinfrancata e rafforzata da questo cibo, non si accomodi, ma, al contrario, si metta in cammino; non si fermi nella sua ricerca, ma la porti avanti con passione e decisione.
Il nome con cui la gente indica il Signore è <Rabbì>! E il Signore come maestro si fa seguire fino a farsi inseguire per obbligare ciascuno a fare un lungo e necessario percorso per verificare se e fino a che punto questa ricerca e questa devozione discepolare siano autentiche. Alla fine di questo lungo capitolo il risultato più significativo sarà proprio la constatazione che se tutti hanno mangiato, non tutti si aprono alla fede sapendone assumere tutte le esigenze connesse. Nel gran movimento di barche – tra gente che salpa e gente che approda – si inserisce la parola esigente del Signore: <In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati>. Questo ha una conseguenza assai chiara che fa la differenza: <Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà> (6, 26-27). Potremmo tradurre tutto questo come una provocazione da parte del Signore: “se mi volete come rabbì, dovete imparare ad essere docili e non semplicemente grati”.
La figura di <Stefano, pieno di grazia e di potenza> (At 6, 8) diventa così icona del discepolo autentico che si fa in tutto conforme, non solo agli insegnamenti del maestro, ma soprattutto al suo stile e al suo modello di vita. Il segno di questa intima docilità che si fa conformazione nella vita e nella morte, è la condivisione della stessa sorte che crea lo stesso atteggiamento di rifiuto: <Lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio> (6, 11). In realtà Stefano non ha mai detto – come del resto il suo Signore e Maestro – nessuna parola blasfema, ma ha messo in crisi quel sistema di controllo e di potere che è l’unica vera blasfemia perché è il risultato dell’idolatria di se stessi.


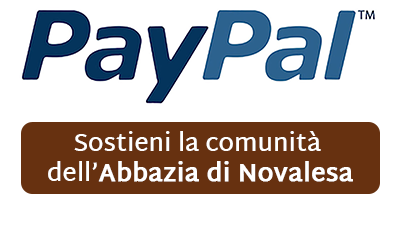


Deo gratias!