Il tuo nome è Stare, alleluia!
III Domenica di Pasqua –
L’evangelista Giovanni ci porta ben lontano, veramente al largo nella necessaria comprensione del mistero di Cristo che, Risorto dai morti, continuamente ci precede nelle vie della vita. Mentre gli apostoli cercano di ritrovare se stessi dopo il dramma pasquale ritrovando la vita di sempre, il Signore Risorto <stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù> (Gv 21, 4) mentre il Maestro sapeva bene chi erano i suoi discepoli. La Pasqua ha cambiato realmente tutto e in modo così radicale che non basta riprendere le abitudini di prima per ritrovare il proprio cammino. È necessario, per così dire, fare i conti con la Pasqua e il Signore Gesù sta sulla riva per aiutare e accompagnare i discepoli e non far finta di nulla e a non dimenticare… anzi a fare memoria e quindi essere in grado di fare un passo avanti nella loro comprensione del mistero della vita piuttosto che cercare in tutti i modi tornare indietro.
Se ci lasciamo guidare dalla sapienza della Liturgia possiamo mettere in parallelo il passo dell’Apocalisse con ciò che ci viene raccontato dal Vangelo. È come se si trattasse di due liturgie: una celeste e l’altra terrestre, una cultuale e l’altra esistenziale. Eppure, sarebbe proprio la riva del lago ad essere il luogo più giusto e più vero che sciogliere il proprio cuore nell’acclamazione: <A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli> (Ap 5, 13). Si potrebbe osare un’immagine che rasenta la banalizzazione irriverente, ma che pure rischia di essere particolarmente efficace: nel mistero dell’abbassamento pasquale del Verbo fatto carne, Dio ormai <siede sul trono> come una madre di famiglia sta ai fornelli per poter invitare tutti con amorevole allegrezza: <Venite a mangiare> (Gv 21, 12).
La conclusione della prima lettura ci attesta come e quanto, in realtà, gli apostoli, infine, sono stati capaci di entrare nel mistero della risurrezione fino a saper rischiare e donare tutta la loro vita: <Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù> (At 5, 41). La fecondità pasquale se è il frutto maturo del cammino di Gesù in mezzo a noi, rappresenta anche una rottura radicale nel modo della sua presenza. Ciò viene suggerito da una sorta di trasformazione numerica che, per gli antichi, è il modo più adeguato per indicare un radicale e irreversibile mutamento del reale. I discepoli non sono né i Dodici, né gli Undici degli altri racconti della risurrezione – questa è infatti la <terza volta> – sono ormai sette, numero che indica la pienezza e la perfezione come nel settenario della creazione. Ma soprattutto essi non vengono ricordati con l’evocazione di un numero, ma con la precisa ripetizione del nome di ciascuno dei primi tre, l’evocazione del legame di altri due e un numero, infine, che lascia aperto ogni nome possibile: <si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli> (21, 2). A questo compare un modo nuovo di porsi: <Io vado a pescare> cui segue un <Veniano anche noi con te> (21, 3). Vi è un’ultima parola del Risorto: <Seguimi> (21, 19). Ormai è il tempo della solitudine, del cammino della fede vissuto, certo e necessariamente, in comunione profonda con gli altri discepoli, ma aperti all’irriducibile dell’esperienza personale che è unica e irripetibile: <… e ti porterà dove tu non vuoi> (Gv 21, 18).


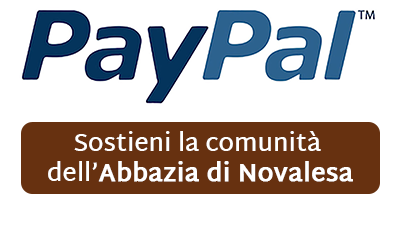


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!