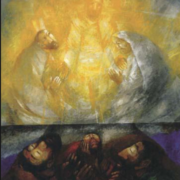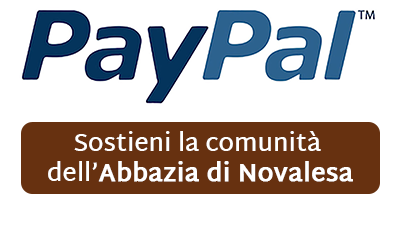Pregato
XIX settimana T.O. –
La reazione del padrone con il servo di cui ha avuto pietà risuonano anche nel nostro cuore come sottile rimprovero che ci ammutolisce: <Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato> (Mt 18, 32). Il seguito del testo dà a questa parola del Signore Gesù un peso importante perché la pone come conclusione di una sezione del vangelo secondo Matteo: <Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano> (19, 1). Il lungo e articolato cammino che il Signore Gesù fa fare ai suoi discepoli per prendere coscienza di quella che è la logica in cui vivere i loro rapporti fraterni e che fa della Chiesa un vero e delicato laboratorio di umanità, termina con un rimando alla vita interiore e più specificatamente alle condizione e alle conseguenze della nostra preghiera. Come il popolo varca le porte della terra promessa attraversando il Giordano, così il Signore – sempre attraverso il Giordano – entra in Giudea avvicinandosi così al suo mistero pasquale in cui l’Innocente si farà icona del Padre che ama fino alla fine e per questo non può che perdonare oltre ogni fine.
Nella preghiera, infatti, presentiamo al Padre quelle che sono le nostre necessità e, ancor più spesso, mettiamo davanti a Lui le nostre fragilità e le nostre impotenze. Proprio nella preghiera ci è dato di fare esperienza non sempre di essere esauditi – almeno per quelle che sono le nostre aspettative immediate e i nostri tempi di realizzazione immediata – ma sempre facciamo esperienza di essere accolti. Secondo la parola del Signore Gesù tutto ciò dovrebbe dare al nostro cuore una capacità crescente di fare altrettanto con i nostri fratelli e sorelle in umanità. Per questo persino quando non possiamo esaudire, dobbiamo sempre accogliere il mistero della debolezza e del bisogno dell’altro che si fa preghiera: <Abbi pazienza con me e ti restituirò> (18, 29).
Nella vita di ciascuno di noi, come discepoli, e nella missione della Chiesa quale segno di salvezza per l’umanità, tutta la preghiera che si fa perdono radicale in quanto ci aiuta ad assumere fino in fondo la realtà impotente dell’altro si fa rivelazione. Si tratta di una rivelazione di presenza – quella di Dio – che ci strappa alle nostre paure di proseguire e osare nonostante tutto il viaggio nelle terre sempre sconosciute e un po’ selvagge della relazione. La parola che il Signore Dio rivolge a Giosuè, alla vigilia del passaggio del Giordano che segna la fine dell’esodo e l’inizio della sedentarizzazione nella terra promessa, può valere ogni volta che osiamo entrare nella terra – necessariamente diversa – della relazione con l’altro: <Da ciò saprete che in mezzo a voi vi è un Dio vivente…> (Gs 3, 10). Il popolo di Israele si aspetta che Dio scacci tutti gli altri proprio come noi ci auguriamo di non doverci confrontare troppo con gli altri. Per questo, attraverso la preghiera, impariamo ad assumere l’atteggiamento di Dio stesso che condona a tutti a ciascuno il <debito> (Mt 18, 32) della propria realtà umana normalmente per quanto diversamente povera e indigente. L’arca che i sacerdoti introducono nella terra degli altri per renderla santa e riconosciuta come ormai la propria, può essere assunta quale simbolo di quel lavoro quotidiano della preghiera in cui impariamo a perdonare <di cuore> (18, 35) dopo aver sperimentato il dono incommensurabile di essere stati perdonati più che di cuore dal Padre.