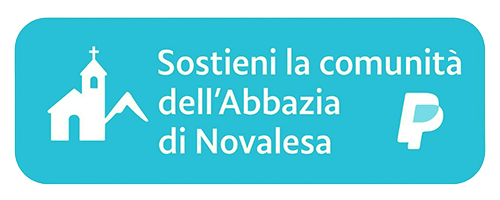Prova
XXVII settimana T.O. –
L’amara constatazione del profeta Gioele risuona in termini di nostalgia e, al contempo, di desiderio: <perché priva d’offerta e libagione è la casa del vostro Dio> (Gl 1, 13). Quella di Gioele potrebbe forse fungere da fondamento biblico a qualche campagna di raccolta fondi per i bisogni della chiesa e del suo clero o di altre iniziative simile ed è, invece, la rammemorazione di un dinamismo d’amore che esige sempre la disponibilità e l’esigenza del donare. La casa di Dio di cui il tempio è simbolo eloquentissimo non si può limitare ad essere il luogo del culto, ma si estende a tutti gli ambiti della vita e, in particolare, alla collaborazione generosa per dilatarne e sostenerne i percorsi che donano più vita e che sono in grado di dare, altresì, più senso ad ogni esistenza. Ed ecco che il gesto compiuto da Gesù che scaccia, ancora una volta, un demonio, scatenando una strana reazione da parte di quanti, per primi, avrebbero dovuto rallegrarsene: <E’ per mezzo di Beelzebùl, capo dei demoni, che egli scaccia i demòni> (Lc 11, 15).
Per i farisei definire l’origine di qualcosa significa, in realtà, creare un legame e una reciproca connivenza cosicché, il Signore stesso, sarebbe alla fine un <demonio>. Nondimeno da parte del Signore Gesù vi è un atteggiamento che è agli antipodi di quello di Beelzebul. Egli, infatti, non cerca di disperdere e di contrappore, ma al contrario intende unire e creare una profonda solidarietà tra tutti coloro che hanno bisogno di aiuto e quanti possono sostenerli ed aiutarli nel loro cammino di liberazione. La solenne e ambigua affermazione che ritroviamo appena prima e che in forma inversa è rivolta al discepolo Giovanni (9, 50) suona in questo caso così: <Chi non è con me, è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde>. (11, 23) Essa non va intesa come una dichiarazione di guerra, ma bensì come una proposizione che intende unire tutte le forze migliori affinché si oppongano all’opera disintegrante e mortificante del Maligno.
Il Signore Gesù sembra disapprovare ogni tentativo di contrapposizione ed invita a cogliere e a valorizzare ogni minimo <segno> (11, 16) che faccia sperare in un’aurora di maggiore e più autentica libertà per ogni uomo, per tutto l’uomo e per tutti gli uomini. Il rischio è, infatti, quello che, a forza di volere definire e sottilizzare, si lasci campo libero proprio a ciò che va energicamente arginato. Il pericolo più grande è che le cose peggiorino quando ci sarebbero tutte le condizioni, tanto che si dice: <Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l’ultima condizione di quell’uomo diventa peggiore della prima> (11, 26). In questo frangente ci è forse più chiaro l’invito di Gioele: <Suonate il corno in Sion e date l’allarme sul mio santo monte!> (Gl 2, 1). Diamo l’allarme per arginare tutto ciò che impedisce alla vita di crescere e di dilatarsi e, soprattutto, per neutralizzare e superare ogni sguardo malevolo poiché, per chi ha occhi e cuore come quelli del Signore Gesù la parola è vera: <Come l’aurora, un popolo grande e forte si spande sui monti: come questo non ce n’è stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri, di età in età> (2, 2).