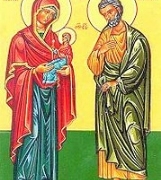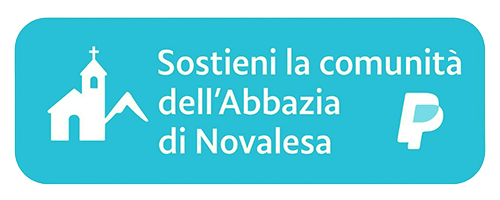Levier
Exaltation de la Sainte Croix –
Célébrer le mystère de la Croix en dehors du propre contexte de la célébration pascale est une façon de dire encore – une fois de plus – comment et quand la réalité de la croix marque le chemin de nos vies de manière quotidienne. Dans la relecture que Paul donne du mystère intégral du Christ Seigneur, il semble que l’apôtre ait trouvé – non sans difficulté – la clé pour interpréter et témoigner : « Il s’est fait serviteur lui-même assumant la condition de serviteur » ( Ph 2, 7 ). Dans ce verbe « assumer » l’on peut trouver les raisons de la révélation de Dieu en Christ Jésus, mais aussi les raisons de notre quotidien pour assumer le don de la vie avec tout le poids que cela comporte. Ce verbe assumer, semble englober une espèce de suspension de jugement qui change radicalement la façon d’affronter la joie et la difficulté de vivre. Assumer semble d’avantage au fait d’une réalité qu’à un choix. Choisir la croix serait même un peu ambigu, alors qu’assumer la croix est un acte d’une grande dignité humaine libérée de tout anxiété de performance.
A côté du verbe « assumer », la Liturgie nous rappelle le verbe « élever ». C’est le Seigneur Jésus lui-même qui explique à Nicodème ce qu’il y a au coeur et à la racine de sa personne : « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut ainsi que soit élever le Fils de l’Homme, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle » ( Jn 3, 14-15 ). L’on pourrait dire que le mystère de la croix est comme le levier d’Euclide qui permet avec un minimum d’effort de soulever de grands poids sans risquer de plier en quatre son âme. Nous pensons souvent à la croix comme à l’emblème de la souffrance, plus ou moins acceptée ou plus ou moins subie. La fête de ce jour nous aide à lire dans la croix son côté glorieux qui n’élimine rien de la difficulté ni de la rébellion face à la souffrance, mais qui nous renvoie aussi à nous-mêmes pour être capable d’assumer un attachement qui nous permet de nous élever sans nous esquiver. Le levier n’est pas la résignation, mais plutôt la croissance quotidienne d’un peu plus d’amour comme capacité de sortir de soi pour se donner entièrement sans jamais se laisser anéantir par sa propre liberté de don : « Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui » ( Jn 3, 17 ).
Le commentaire qui ouvre la Liturgie de la Parole qui accompagne cette fête parle aussi de nous : « Son peuple ne supporta pas le voyage » ( Nb 21, 4 ). Nous faisons tous partie d’un peuple en chemin vers la liberté avec toutes les joies et les difficultés propres à ce voyage essentiel. La suite de la narration semble nous rappeler que chaque fois que nous ne supportons pas le voyage de la vie, avec ses défis et ses exigences, il est nécessaire de faire face à nos rébellions intérieures comme s’ils étaient « des serpents brûlants » ( 21, 6 ) , comme pour récupérer la capacité de regarder un peu plus haut, un peu plus loin. La croix devient ainsi un point d’orientation qui nous permet et nous oblige à ne pas imploser. La croix représente le levier par lequel, dans notre faiblesse, nous devenions capables de soulever le monde sans laisser le poids nous écraser.