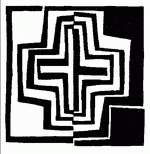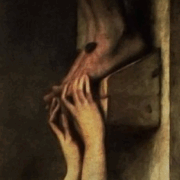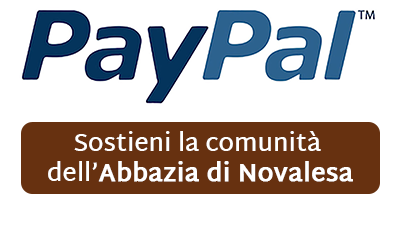Il tuo nome è Storia, alleluia!
Lunedì di Pasqua –
Al mattino dopo quel primo mattino che segue il grande Sabato è come se rimpiombassimo a valle della storia. L’evocazione delle guardie ancora una volta prezzolate e l’inizio della lettura annuale degli Atti degli Apostoli sono il modo efficace con cui la Liturgia ci tiene sulla corda… sulla corda della storia. La risurrezione di Cristo Signore non rappresenta una comoda fuga dalla storia né, tantomeno, una sorta di sogno per tenere buone le coscienze. La risurrezione è un fuoco gettato sulla terra per impedire in tutti i modi che si sprofondi nella dimenticanza di come la forza che viene da Dio – lo Spirito Santo evocato con così grande forza da Simon Pietro – è all’opera in misura proporzionale allo spazio che gli diamo dentro la nostra vita concreta. Nemmeno la risurrezione può mai essere un’evidenza che costringe a credere, ma è una porta che permette e obbliga ciascuno a scegliere. Questo è avvenuto al mattino di Pasqua, questo avviene ogni mattina in cui la nostra umanità si rimette in cammino sulla strada della vita scegliendo di farsi pagare o accettando di pagare.
La lettura degli Atti degli Apostoli ci aiuteranno a comprendere come la risurrezione si fa storia nella vita delle prime comunità di discepoli in modo incarnato, concreto con momenti di grande luminosità e momenti terribilmente umbratili. Ancora una volta gli uomini da una parte e le donne dall’altra! Neppure la luce pasquale può evitarci il dramma della scelta che non si impone mai come un’evidenza che non lasci scampo alla nostra libertà, ma la impegna radicalmente tanto che nessuno – nemmeno l’Altissimo – può scegliere al nostro posto o prendere posizione davanti alla storia sollevandoci dal peso della nostra responsabilità, dalla gioia di dare una risposta alla storia anche quando sembra che tutto sia finito e i giochi definitivamente conclusi.
Da una parte gli uomini – i discepoli e i soldati – si nascondono a se stessi per evitare fastidi, mentre le donne si fanno incontrare realmente dal Risorto e in modo nuovo proprio perché si erano levate di buon mattino per andargli incontro a loro modo. Messesi in cammino per seguire il loro cuore, le donne hanno la grande sorpresa di poter ritrovare il Signore tanto che <si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono> (Mt 28, 9). L’apostolo Pietro, al mattino di Pentecoste, ritrova se stesso e si sente animato da un coraggio che non gli appartiene, ma che gli viene donato: <Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere> (At 2, 24). Sarebbe meglio tradurre la parole di Pietro con doglie del parto poiché il termine greco indica i legami e le doglie. Paolo usa questo termine per indicare la nascita di un mondo nuovo nella creazione nuova. La storia, ogni storia piccola o grande, rilevante o sconosciuta può riprendere il suo cammino solo nella misura in cui qualcuno – come le donne al mattino di Pasqua – accetta di rischiare la speranza e non – come i soldati – di barattarla con la rassicurazione di essere liberati da <ogni preoccupazione> (Mt 28, 14).