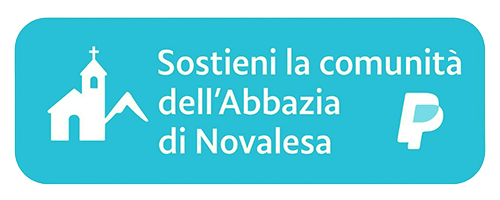Salire
XXV settimana T.O. –
Nel più profondo della tenebra della disperazione dell’esilio che col tempo si è trasformata, nel cuore del popolo, in abitudine e rassegnazione, si leva – infine – una luce. Questa luce si incarna in un appello che non solo viene da lontano, ma proviene da dove nessuno se lo aspetterebbe né, tantomeno, lo spererebbe. Ciro, re di Persia, un re straniero e pagano si fa mediazione di un nuovo inizio per il popolo di Dio forse addormentato nel proprio dolore e la cui sofferenza – come accade anche a noi – rischia di indebolire la speranza e l’audacia: <Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e salga a Gerusalemme, che è in Giuda, e costruisca il tempio del Signore> (Esd 1, 3). Due verbi risuonano nell’appello regale ad un popolo ormai abituato ad essere rassegnato e, in molti casi, ben adattato ad una situazione di schiavitù e di sudditanza: salire e costruire!
Due verbi che invitano a riprendere coraggio e soprattutto che invitano a ritrovare un dinamismo di vita che rimette in cammino e riaccende la fantasia. Salire e costruire indicano un movimento interiore che accompagna la storia dell’umanità nei suoi momenti migliori. Questi verbi hanno lasciato il segno nella storia attraverso dei monumenti che sono testimonianza di ciò che l’uomo è capace quando riesce a sperare. Il Signore Gesù radicalizza questo invito con l’immagine della bellezza del fuoco – piccolo o grande che sia – il quale per sua natura va verso l’alto e diffonde attorno a sé un chiarore che permette alla vita di dilatarsi e di rivelarsi nella sua bellezza. Allora è chiaro che <Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce> (Lc 8, 16). Se il re Ciro invita il popolo a salire e a costruire, il Signore Gesù invita i suoi discepoli a vivere in modo luminoso e gioioso senza cedere alla tentazione di ripiegarsi su se stessi o di rinchiudersi nella coltre di una paura che paralizza la vita.
Il segreto di questa luce, la sua scaturigine profonda che la rende invincibile, è la qualità dell’ascolto. Per questo il Signore Gesù esorta vivamente: <Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere> (8, 18). Il Signore Gesù fa del nostro modo di ascoltare un modo di essere e di stare al mondo che diventa, in modo del tutto naturale, un modo per donare. Ciascuno di noi ha ricevuto un dono di cui è responsabile non solo per se stesso, ma anche per ciò che esso può significare per gli altri, cosicché non possiamo soffocare la luce di cui siamo portatori e non possiamo privare noi stessi e gli altri della speranza di cui, in modo talora misterioso, siamo comunque testimoni. La conclusione della prima lettura potrebbe indicare il dinamismo che rianima i nostri cuori ogni mattina: <Allora si levarono… a tutti Dio aveva destato lo spirito, affinché salissero a costruire il tempio del Signore che è a Gerusalemme> (Esd 1, 5). Salire e costruire in ogni momento il tempio di una presenza di Dio in mezzo alla storia cominciando dalle nostre relazioni più quotidiane significa, infatti, sperare e far sperare.