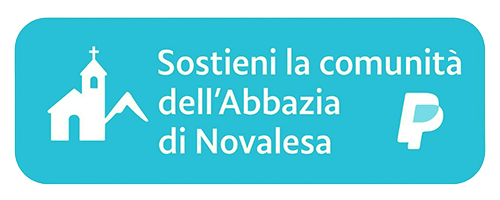Attendere… l’angelo
19 Dicembre T.A. –
Le due letture che accompagnano e guidano il nostro cammino verso il Natale ci parlano, in ambedue in casi, dell’intervento di un angelo nella vita di due persone già segnate amaramente dalla vita attraverso la dura e mortificante esperienza della sterilità. Manoach ha una moglie sterile e una vita molto probabilmente rassegnata, ma ecco che <L’angelo del Signore apparve a questa donna> (Gdc 13, 3). Zaccaria ed Elisabetta <Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le legge e le prescrizioni del Signore> eppure <non avevano figli> (Lc 1, 7). Eppure, proprio quando non si aspettavano più nulla dalla vita se non una vecchiaia un po’ triste e, anche per loro, rassegnata, ecco che <Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso> (1, 11). Il frutto di queste due visite angeliche sono la nascita di <Sansone> (Gdc 13, 24) e quella di Giovanni Battista che sono la prefigurazione della nascita di Cristo non solo nel tempo, ma pure nel profondo dei nostri cuori.
Mentre i nostri passi si affrettano verso la rinnovata contemplazione del <segno> che sarà posto in una <mangiatoia>, siamo invitati ad un pellegrinaggio forse ancora più impegnativo verso l’intimità del nostro cuore dove dobbiamo porci la domanda su quelle che sono le nostre reali attese e aspettative. Forse anche noi come Manoach e sua moglie e come Zaccaria ed Elisabetta rischiamo di vivere in modo rassegnato senza più aspettarci molto dalla nostra esistenza in termini di incremento di vita. Ed ecco che, inaspettatamente ma così gioiosamente, siamo chiamati a confrontarci con un <angelo> del Signore che visita la nostra esistenza e ci apre gli occhi su un di più di possibilità. Nella figura dell’<angelo del Signore> non è necessario immaginare nulla di così straordinario. Se c’è una caratteristica propria degli angeli è la leggerezza del loro passo e la loro assoluta discrezione con cui visitano coloro cui sono inviati a portare un annuncio senza attirare troppo l’attenzione su se stessi e, con un battito d’ala, scompaiono non appena la loro missione di annuncio e di sostegno alla speranza è stata compiuta.
Se riflettiamo bene di angeli e di momenti angelici anche la nostra vita è piena! Il vero problema riguarda la nostra disponibilità ad accogliere e a lasciarci rimettere in moto nel desiderio dalla visita di chi ci aiuta ad aprire gli occhi per cogliere nuove e più ampie possibilità di vita. L’annuncio di Gabriele suona per Zaccaria troppo esigente: <Avrai gioia ed esultanza> (Lc 1, 14). Non è raro che la gioia ci spaventi più del dolore perché richiede da noi un di più di generosità e di implicazione. La reazione di Zaccaria rischia di essere molto simile alla nostra: <Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni> (1, 18). A questa reazione quasi imbronciata di Zaccaria corrisponde quella dell’angelo: <Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio> (1, 19). Anche per noi, forse, si rende necessario un tempo <muto> (1, 20) per riconsiderare noi stessi ed abitare quel segreto che ci abita così profondamente, da farci così male da avere bisogno quasi di negarlo. In questi giorni di preparazione al Natale cerchiamo un angolo intimo di silente contemplazione del nostro cuore per potervi ascoltare i sussurri angelici che ci invitano ad andare oltre e a desiderare ancora, di più, meglio. A quanto pare gli angeli parlano sempre al futuro ed è per l’avvenire che dobbiamo ricordare – Zaccaria significa “Dio si ricorda” – per fare sempre più spazio alla grazia della vita – Giovanni significa “Dio fa grazia” -.