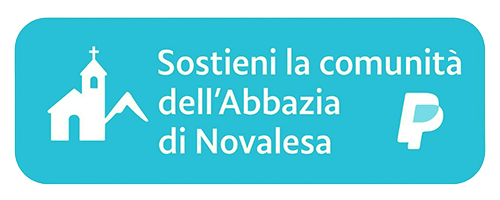Attendere… un messaggio
I Domenica di Avvento –
Il tempo di Avvento e il nuovo ciclo triennale della Liturgia domenicale vengono aperti con una parola che può essere assunta come il vessillo e l’ispirazione di un nuovo tempo di ascolto e di docile conversione, all’insorgere della presenza del Regno di Dio che viene nella nostra storia: <Messaggio che Isaia, figlio di Amoz ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme> (Is 2, 1). Questo versetto introduttorio all’Avvento può essere recepito e accolto come chiave per entrare nel mistero di una rinnovata apertura al mistero di Dio che, ancora una volta, ama e chiede di farsi vita della nostra vita. Se c’è un <messaggio> c’è pure qualcuno attraverso cui questo messaggio viene trasmesso. L’Avvento ci chiede di farci o rifarci doppiamente sensibili: accogliere il messaggio e accettare che esso si possa trasmettere efficacemente attraverso di noi: <La prima venuta fu umile e nascosta, l’ultima sarà folgorante e magnifica; quella di cui parliamo è nascosta, e nello stesso tempo, magnifica. Dico che è nascosta, non perché sia ignota da colui che la riceve, ma perché avviene in lui nel segreto … Avviene senza essere vista e si allontana senza che se ne accorga. La sua sola presenza è luce dell’anima e dello spirito. In essa vediamo l’invisibile e conosciamo l’inconoscibile. Questa venuta del Signore mette l’anima di chi la contempla in una dolce e beata ammirazione. Lo sanno quanti hanno fatto tale esperienza, e voglia Dio che coloro che non l’hanno ancora fatta ne provino il desiderio>1.
Accanto al profeta Isaia che ci accompagnerà lungo queste quattro domeniche nel cammino verso il Natale del Signore, risuona pure la parola dell’apostolo: <questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti> (Rm 13, 11). Il <messaggio> affidato al profeta assume contorni più chiari e diventa un invito alla consapevolezza che ci libera da ogni fuga e da ogni abbaglio della superficialità che apparentemente così vitale è, in realtà, un <sonno dell’anima>. Mentre la liturgia dell’Avvento ci invita ad accendere lumi discreti e soffusi, si accendono, per le strade delle nostre città e per i vicoli del nostro cuore, una serie di luci ammiccanti, così da essere chiamati – anche noi – ad affrontare un piccolo grande combattimento per rimanere consapevoli di ciò che veramente desideriamo, per non lasciarci contaminare dal volere e dal cercare ciò che, in realtà, neppure ci attrae e di cui non abbiamo nessun bisogno. Sempre l’apostolo ci offre un avverbio che può diventare come la nostra piccola lampada alla cui <luce gentile>, come amava pregare il Cardinal Newman, discernere e vivere di desiderio. Questo avverbio è: <onestamente>. Se non sapessimo cosa può significare questo avverbio allora non ci resta che leggere un po’ più oltre <come in pieno giorno> (Rm 13, 13).
Il messaggio da ricevere e da trasmettere è quello di una consapevolezza che si fa onestà nell’accogliere e nell’attraversare la vita di ogni giorno. La parola del Signore Gesù ci riporta a questo mistero di quotidianità che non ha niente a che fare con la banalità: <Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà> (Mt 24, 42). Questa parola del Signore non va intesa e accolta come una minaccia, ma piuttosto come un onore alla nostra dignità di persone sempre e continuamente rimandate alla propria libertà chiamata ad integrare i <due uomini> e le <due donne> che abitano dentro di noi (Mt 24, 40-41). Tenersi pronti non può che essere il segno e il frutto di attendere qualcosa – più precisamente Qualcuno – che ci porta sempre oltre la soddisfazione dei nostri bisogni primari. Il rischio da cui siamo chiamati a tenerci assolutamente vigilanti è quello in cui caddero i nostri padri i quali <non si accorsero di nulla> (24, 39). Una domanda si pone non tanto per loro quanto per noi stessi: non si accorsero di nulla e non vollero accorgersi di niente per evitare di dover scegliere, lasciando che altri scegliessero al loro posto. Teniamo d’occhio le troppe luci di questi giorni e cerchiamo di abbassarle in modo che la notte ci permetta di scorgere le stelle… la Stella.
1. GUERRICO D’IGNY, Discorsi per l’avvento, 2, 2-4 : PL 185, 15-17