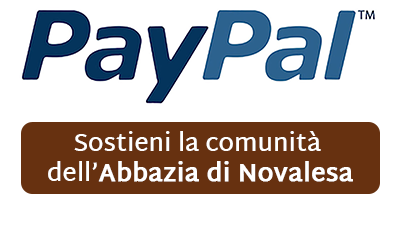Fratelli tutti
Maria Madre della Chiesa –
Non siamo ancora abituati a vivere questa memoria mariana istituita da papa Francesco per il giorno dopo la solennità della Pentecoste. Il testo degli Atti degli Apostoli proposto per la Liturgia della Parola risuona come una sorta di protocollo per la vita della Chiesa di ogni tempo e di ogni luogo: <Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi> (At 1, 13). Laddove i Dodici, quasi certamente accompagnati e non solo serviti dalle donne, avevano vissuto il momento della cena pasquale alla vigilia della passione del Signore, il nucleo fondamentale della prima comunità dei discepoli del Crocifisso Risorto, attende il dono promesso dello Spirito. Secondo la cronologia lucana, se la comunione nella carità è il frutto più maturo dell’effusione dello Spirito, ne è pure la premessa essenziale: <Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui> (1, 14).
Questa memoria voluta da papa Francesco per l’intera Chiesa cattolica assume un significato emblematico alla luce dell’ultima enciclica di papa Francesco firmata sulla tomba del Poverello alla vigilia della sua festa: <”Fratelli tutti, scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va al di là delle barriere della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui”. Con queste poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita>.
Il seme di questa universale fraternità è stato fatto cadere si piedi della croce del nostro amato Signore nel momento in cui redasse il suo testamento di tenerezza con la penna della croce e l’inchiostro indelebile del suo sangue versato: <Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé> (Gv 19, 25-27.
All’indomani dello spegnimento del cero pasquale, che ha rallegrato con la sua colonna di luce le nostre assemblee liturgiche, siamo chiamati a ritornare sotto l’albero della croce. Là possiamo cogliere il frutto non proibito di una tenerezza e di un amore che sono l’univo vero antidoto ad ogni tentazione di regressione all’autoreferenzialità mortifera. La <paura> (Gen 3, 10) sperimentata dalla nostra umanità subito dopo aver acconsentito alla suggestione di potersi dare la pienezza di vita prendendola con le proprie mani, si trasforma in <stupore> (Mc 16, 8) rinnovato. Dopo aver celebrato di nuovo la Pasqua, riprendiamo il nostro cammino nel tempo ordinario nello stupore di un amore che non si lascia vincere da nessuna <paura> perché radicato nella bellezza di camminare insieme e nella promessa che siamo comunque sorelle tutte e fratelli tutti.