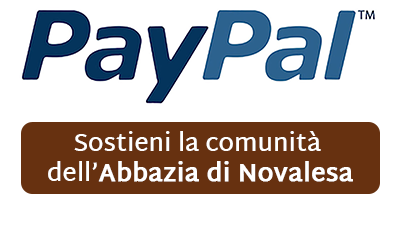Il tuo nome è Cominciare, alleluia!
IV Settimana di Pasqua –
Non dobbiamo affatto sottovalutare quanto ci viene ricordato dagli Atti degli Apostoli: <Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore> (At 11, 20). Sembra che l’allargamento dell’annuncio della salvezza in Cristo riservata fino a questo momento solo ai <Giudei> (11, 19) non sia stata una scelta fatta a tavolino né, tantomeno, una decisione calata dall’alto con un crisma di autorità incontestabile. La predicazione rivolta a tutti cui dobbiamo l’identità di Chiesa che ci sembra oramai la più naturale e la più scontata, nasce da un semplice moto dell’animo di alcuni discepoli che interroga gli apostoli e non li allarma. Siamo chiamati a conservare bene la memoria di questo passaggio epocale nella storia della prima comunità cristiana per non temere, a nostra volta, di cominciare nuovi percorsi e di inaugurare nuovi metodi senza aspettare che questi vengano calati dall’alto con rassicurazione previe e sigilli di autenticazione che solo la vita può dare in modo autenticamente evangelico.
Inoltre, questo passaggio epocale deve rimanere per i pastori della Chiesa un punto di riferimento e un modello di discernimento: non sempre sono i pastori ad intuire le vie migliori e quelle necessarie perché la salvezza sia offerta ad un numero crescente di persone. Il testo degli Atti degli apostoli annota con semplicità che <Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e mandarono Barnaba ad Antiochia> (11, 22). In questo contesto di allargamento dell’orizzonte della predicazione e della missione sembra che si faccia spazio la necessità di un apostolo come Paolo tanto che, proprio in questo frangente, e sempre per un’ispirazione e spinta interiore: <Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo> (11, 25).
Mentre contempliamo il mistero dell’allargamento degli orizzonti della Chiesa di Cristo possiamo sentire tutta la forza e la bellezza della parola del Signore Gesù: <Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono> (Gv 10, 27). Per il Signore non sembra sufficiente fare memoria della nostra sequela, ma ci tiene a sottolineare il suo essere totalmente per noi: <Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano> (10, 28). Eppure, non dobbiamo mai dimenticare che la <mano> del Signore è amplissima ed è capace di racchiudere persino le stelle e le galassie tanto da desiderare che la Chiesa sia sempre più un popolo capace di contenere tutti i popoli, tutte le culture, tutte le sensibilità. La gioia del Vangelo è una letizia che trova il suo segreto della vita nella capacità e quasi nel piacere di ricominciare continuamente lasciandosi interpellare, scuotere e cambiare da quelle che sono le realtà e le necessità che bussano al cuore e chiedono non una semplice tolleranza compassionevole, ma un’accoglienza piena fatta di riconoscimento e di reciproco arricchimento.