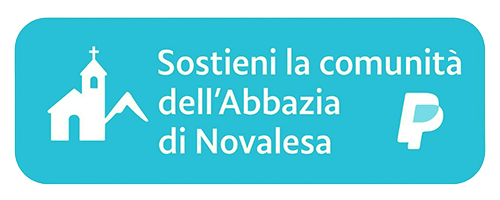Attendere… lavorare
III settimana T.A. –
Una parabola ci viene oggi raccontata per aiutarci a prendere una decisione importante per la nostra vita di discepoli: <lavorare> (Mt 21, 28). In una cultura sempre più ossessionata dal tempo libero e dalla continua programmazione delle vacanze, siamo riportati alla realtà di una vita che non si qualifica per il tempo che ci lascia libero, ma a partire dal modo in cui siamo impegnati a fare del tempo e dello spazio, in cui viviamo, una vera partecipazione all’opera del Creatore. Pertanto, il Signore Gesù ci ricorda pure che compiere <la volontà del padre> (21, 31) non si limita a dare una “bella risposta” teorica che cerchi di non deludere e di non contraddire, ma è qualcosa che esige delle scelte concrete di vita ed è impastata con la nostra vita per quella che è nella realtà e non per quello che ci piacerebbe fosse nel nostro immaginario.
Il primo grande messaggio che ci viene dato dal Signore Gesù è quello della libertà di poter dire senza paura e con una certa sfrontatezza: <Non ne ho voglia> (21, 29). A questa reazione così adolescenziale del primo dei due figli, non corrisponde da parte del padre nessuna punizione e nemmeno un rimprovero. Sembra proprio che il padre proponga a ciascuno dei suoi figli un percorso nella piena libertà che essi vi aderiscano o meno senza nessun timore di essere né disapprovati né tantomeno puniti. In questo il Padre dei cieli, il Padre di tutti, l’unico Signore e Creatore viene rivelato dal Figlio – primogenito ed unigenito – come completamente diverso dall’atteggiamento dei capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo spesso preoccupati di salvare le apparenze e di giudicare gli altri a partire dalle apparenze per giustificare sempre più ampiamente se stessi.
Le cose, ci ricorda il Signore Gesù, non stanno così e rischiano proprio di essere al contrario di quello che noi pensiamo, immaginiamo e, forse, sottilmente desideriamo per sentirci un po’ migliori: <In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio> (21, 31). Il salmo ci aiuta a comprendere la ragione profonda di questa verità: <il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti> (Sal 33, 19). Il segreto e la bellezza della nostra relazione con Dio sono racchiusi in quel misterioso e intimissimo istante in cui il figlio che è dentro di noi <si pentì e vi andò> (Mt 21, 29). Essere parte di quel <popolo umile e povero> (Sof 3, 12) di cui parla il profeta Sofonia significa, infatti, accogliere la <correzione> (3, 2) senza paura e senza <vergogna> (3, 11). Significa <lavorare nella vigna> (Mt 21, 28) del proprio cuore con coraggio e impegno, ma non in modo servile. Risuona severa e dolcissima l’esortazione di un Padre della Chiesa: <Sia chiara la tua condotta di convertito! Tu che hai preferito l’umano al divino, che hai voluto essere schiavo del mondo piuttosto che vincitore del mondo col Signore del mondo, convertiti. Tu che hai perso la libertà che ti avrebbero dato le virtù perché ti sei sottoposto al giogo del peccato, convertiti; convertiti davvero tu che, per paura di possedere la Vita, ti sei consegnato alla morte>1.
1. PIETRO CRISOLOGO, Discorsi, 167.