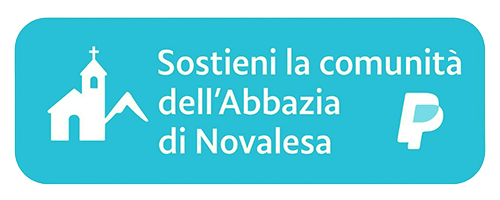Accogliere…
MADRE di DIO –
Nell’ottava del Natale del Signore risuona, quasi per ravvivare la contemplazione del mistero dell’incarnazione, la parola di Paolo: <Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna> (Gal 4, 4). La Madre di Dio – Maria di Nazareth – ha accompagnato, in modo singolare, tutto il nostro cammino di Avvento e fa tutt’uno con <Giuseppe e il bambino> (Lc 2, 16). Nella scena che si presenta ai pastori non è comunque facile abituarsi, fino in fondo, a questa idea: Dio nato da donna! I primi secoli della vita della Chiesa furono attraversati da molti turbamenti proprio a ragione di questo legame inscindibile tra la Madre e il Figlio di Dio. Non era certo facile da metabolizzare nella cultura ellenistica che una donna fosse <veramente Madre di Dio> come si canta continuamente nella liturgia bizantina. Per gli antichi intuire e dire questo mistero richiedeva una grande fatica intellettuale. Per noi, supportati da secoli di riflessione teologica, la sfida è forse più esistenziale per far lavorare in noi il mistero della divina maternità di Maria dando il frutto da sempre atteso e sperato: <riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli> (Gal 4, 5). Contemplare Maria, quale Madre di Dio, significa rientrare a nostra volta in noi stessi per imitare il tratto più umano-divino di questa donna come noi. In Maria risplende quel modello di umanità possibile e altamente desiderabile riassunta con un primo piano dall’evangelista Luca: <Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore> (Lc 2, 19). Forse tra le cose che la Madre di Dio medita nel suo cuore c’è proprio l’esperienza di benedizione: poter vedere così da vicino <il suo volto> (Nm 6, 25). La benedizione riservata ai sacerdoti che invocavano la divina protezione con le parole: <Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia> (6, 24) è ora offerta a tutti da una donna. Maria, madre del Signore, ci offre di accogliere la benevolenza divina in un bambino <adagiato nella mangiatoia> (Lc 2, 16). Questo bambino può essere non solo <visto> (2, 17), ma anche toccato e abbracciato. Tutto questo cambia il corso della storia facendola ripartire dalle donne e dai bambini… dai più poveri e i più piccoli. Sejourner Truth così si interrogava lottando per i diritti delle donne: <Quel piccolo uomo in nero laggiù dice che una donna non può avere gli stessi diritti di un uomo perché Cristo non era una donna. Ma da dove è venuto il vostro Cristo?>. La solennità con cui iniziamo il nuovo anno ci obbliga a non dimenticare di ripartire col piede giusto. Dobbiamo ripartire sempre da ciò che non si può imporre da sé come un <bambino>, ma chiede di essere accolto con amore. Siamo chiamati a stupirci di nuovo del prodigio di ogni maternità che si invera in ogni uomo e donna che si prende cura di chi è più debole e fragile.