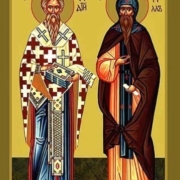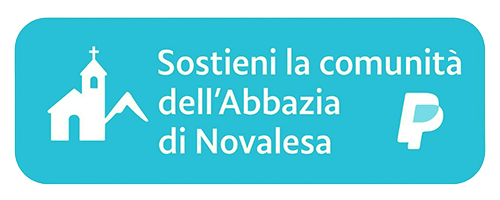Convertire… avanti!
Giovedì dopo Le Ceneri –
Il libro del Deuteronomio sembra avere una grande e una sola preoccupazione attorno alla quale tutto, nella vita e nel cammino del popolo e del singolo credente, sembra ruotare: <Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti ad altri dèi e a servirli…> (Dt 30, 17). Uno sforzo di resistenza sembra impegnare l’anima del credente ed è l’impegno costante a non cedere alla tentazione di volgersi indietro per concentrare, invece, tutta la sua attenzione e tutte le sue forze a guardare avanti e a volgersi verso Dio come qualcosa che non sta dietro di noi, ma che sempre ci precede e ci richiama a riprendere ogni giorno il cammino che ci porta, attraverso l’adesione profonda al mistero del nostro cuore, ad una scelta che sia di <vita> (30, 15). La parola del Signore Gesù sembra dare concretezza a questo invito ponendo una condizione che, in realtà, non è altro che una vera e propria chiarificazione: <Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua> (Lc 9, 23).
Si potrebbe riassumere il messaggio che accompagna e orienta i nostri primi passi quaresimali in una parola: mettersi quotidianamente dietro a Gesù per non volgersi mai indietro e andare sempre e solo avanti. Non è difficile immaginare come sia proprio la <croce> nel suo innegabile mistero di sofferenza e di contraddizione ad obbligarci a raccogliere le forze e a concentrarci interamente su quello che è il passo che stiamo per compiere senza indulgere a inutili retrospettive che non farebbero altro che farci perdere ulteriormente tempo ed energie. Se è vero che la parola del Signore si rivolge a ciascuno di noi: <Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà> (9, 24) e ancora più vero che questa parola radica in una constatazione che si fa accettazione piena e consapevole di un modo di stare al mondo che è un vero darsi senza sconti: <Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno> (9, 22).
Da dove viene al Signore Gesù questa chiarezza così inquietante per i suoi discepoli? Certo dalla sua profonda unità con il Padre, ma anche dalla sua capacità di radicare nella storia e nella vita tanto da conoscerne le leggi e i meccanismi più segreti e più fondamentali che fanno guardare avanti nella speranza di <risorgere il terzo giorno>, senza cadere nell’illusione del prezzo amaro che comporta ogni cammino di autenticità capace di non fare sconti a se stessi. Il nostro cammino quaresimale è ancora neonato, eppure la Liturgia ci porta all’essenziale quasi per non permetterci di perdere tempo e di decidere, nella libertà e nella consapevolezza, il cammino che vogliamo abbracciare per essere <come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo> (Sal 1, 3). Dagli alberi e dalle piante possiamo e dobbiamo imparare a stendere le radici e i rami sempre avanti: verso le profondità della terra e le altezze del cielo in un movimento apparentemente così diverso eppure così unico. La parola interrogativa del Signore non può che scavare dentro: <Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?> (Lc 9, 25). In realtà siamo chiamati a percorrere un lungo cammino interiore che ci porti non solo a scegliere la <vita e il bene> (Dt 30, 15) ma il Vivente che ha dovuto <soffrire molto> (Lc 9, 22) perché ha voluto.