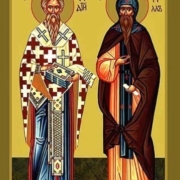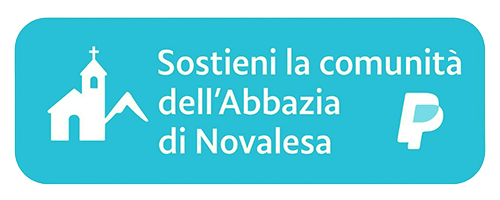Fratelli monaci
V Settimana T.O. –
Michele e Costantino diventano rispettivamente Metodio ossia “colui che fa le cose bene” – possiamo dire: “con metodo”? -, secondo un etimo popolare, e Cirillo cioè “il piccolo signore”, anche in questo caso secondo con etimologia popolare. I due nomi monastici rispecchiano quali siano state la vocazione e la missione dei due fratelli eruditi ed evangelizzatori sino ad “inventare” un alfabeto per cercar di trascrivere una lingua fino allora solo parlata, affinché un popolo avesse le sue memorie e fosse padrone in certo modo della propria storia e del proprio destino. Impegnati a dare ai popoli slavi la Parola attraverso la parola i due fratelli consumano la loro vita tra durezze e contrasti con un mondo, anche ecclesiastico, che non li capisce.
Il testo di Luca che oggi ascoltiamo ci porta a riflettere sulla loro identità profonda. Il passo evangelico che viene proposto per questa festa è, infatti, preceduto da due importanti episodi: la ferma decisione di Gesù di salire a Gerusalemme (9, 51) e l’evocazione della solitudine che attende colui che è chiamato alla sequela del Signore (9, 57ss). Questi due episodi ci fanno capire come mai gli operai siano “pochi” (10,2). È inevitabile che sia così: la sequela comporta un indurire la faccia e un accoglimento della propria solitudine alla scuola del Signore Gesù che non tutti possono consapevolmente accettare.
La sequela esige decisioni dure e impopolari, come quella dell’Apostolo di volgersi ai pagani (At 13, 46), con tutti i rischi che essa può comportare. Eppure, è solo abbracciando la propria solitudine in nome di una chiamata che si può imparare a viverla e ad amarla. Perché non ci si può aprire all’universalità cantata ed invocata nel salmo responsoriale senza un certo distacco dal proprio mondo. Né si può costruire una vera comunione con qualcun altro senza una previa separazione dal proprio ambiente: è una specie di legge che troviamo già inscritta nella creazione (Gen 2, 24). È un po’ la legge del detto popolare “non si può avere tutto”. Esistono necessarie prese di distanza che sono, in realtà, momenti di dolorosa crescita. Perciò gli operai non potranno mai essere molti. Se a noi è chiesto di pregare è perché essi siano il più possibile pronti per le esigenze del loro lavoro apostolico, ossia per una vita <totalmente dedicata all’attività apostolica> e, nel caso dei due fratelli, alla <intuizione divina di rendere comprensibile e accessibile il messaggio della Rivelazione alle popolazioni> slave, che <fu motivo di unità per tradizioni e culture differenti>1. L’iconografia ci presenta Cirillo e Metodio sempre ieratici e come impassibili, rivestiti di splendidi paramenti che non rivelano la vita povera e durissima che certamente essi hanno condotto. Secondo l’icona, infatti, non conta la cronaca di quanto soffrirono, ma la gloria che hanno raggiunto. Tale gloria è stata, infatti, a ben caro prezzo, come sempre accade a coloro ai quali preme soltanto che la parola del Signore si diffonda (At 13, 49) e sia glorificata.
1. BENEDETTO XVI, Discorso ai pellegrini dell’ex Macedonia del 23 Maggio 2011.