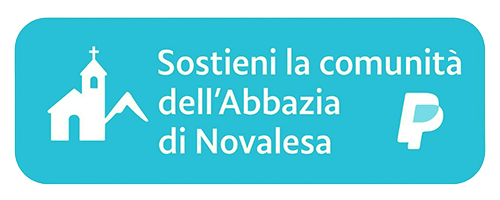Abbondante
Santi Timoteo e Tito –
La parola con cui il Signore invia i suoi discepoli ad annunciare la presenza del Regno di Dio indica una dismisura e un paradosso che sembrano irrinunciabili per una missione che non sia semplicemente un contenuto dottrinale – per quanto elevato – ma uno stile di vita capace di farsi lievito nella realtà di un modo evangelico di vivere, di sentire, di reagire. Da una parte il Signore ricorda ai settantadue discepoli che <La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!> (Lc 10, 2) e dall’altra chiede loro di non attrezzarsi troppo, anzi di non attrezzarsi affatto: <non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada> (10, 4). Sembra che l’ampiezza del lavoro cui i discepoli sono chiamati non debba in nulla metterli in agitazione. Al contrario il Signore chiede una misura ancora più grande di fiducia non in se stessi, nei propri mezzi e persino nell’annuncio di cui sono portatori, ma negli altri verso cui i loro passi vengono indirizzati in una semplicità e libertà. Questo stile, che si fa tratto inconfondibile, è già annuncio e testimonianza di un modo nuovo di approcciare e di presentarsi: <Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa> (10, 7) e nello stesso tempo non può pretendere in alcun modo di essere ricompensato.
Alla <messe abbondante> che rischierebbe di esasperare, il Signore sembra contrapporre una fiducia interiore ancora più abbondante da essere capace di donare ai suoi discepoli persino la serenità di affrontare l’inevitabile rifiuto senza nessun vittimismo né alcuna recriminazione: <ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi> (10, 3). Sembra che la vera preoccupazione del Signore non è che i suoi discepoli siano risparmiati, ma che abbiano il coraggio di rimanere sempre e comunque dei veri <agnelli>. Ciò che nella Colletta dell’Eucaristia dei santi Timoteo e Tito viene evocata e invocata come <scuola degli apostoli>, sembra non essere altro che questa leggerezza interiore che permette di coniugare al realismo di uno sguardo disincantato e preciso sulle situazioni, una fiducia invincibile. Proprio e solo questa fiducia rende possibile continuare a seminare e a mietere senza nessun calcolo e con una gratuità che diventa un vero e proprio stile di vita e, in particolare, stile di relazione.
Lo ricorda con dolcissima forza l’apostolo Paolo scrivendo a uno dei suoi discepoli e collaboratori più stimati e amati: <Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza> (2Tm 1, 7). La <medesima fede> (Tt 1, 4) da cui Paolo sente di essere intimamente legato a Tito diventa una sorta di forza interiore che permette continuamente di comunicare il meglio di sé creando attorno a sé un <ordine> (1, 5) che è quello di un amore e di un’attenzione sempre più profonde e autentiche.